Archivio
-
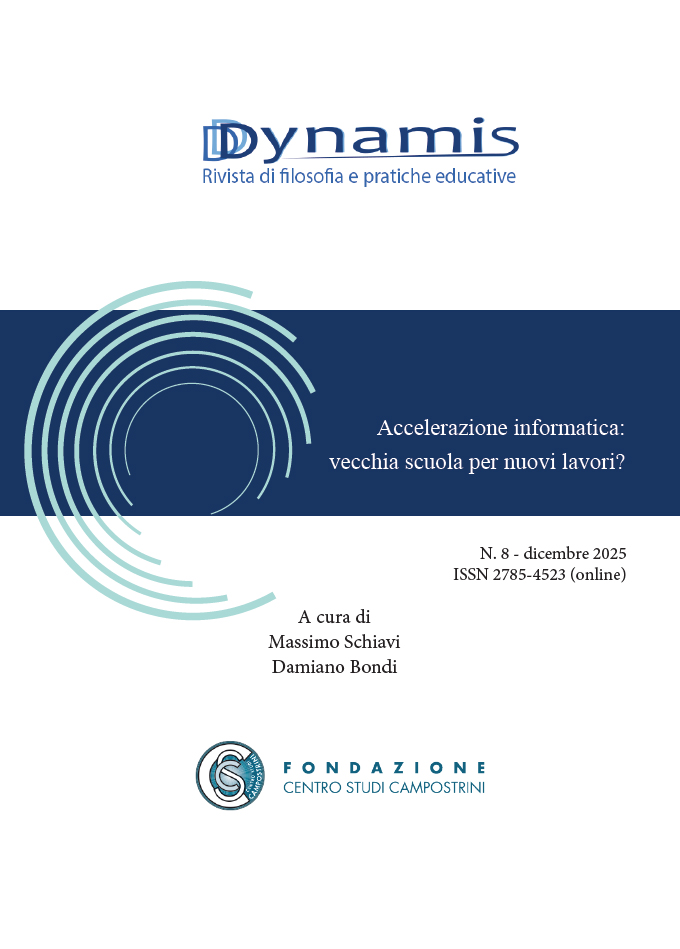
Accelerazione informatica: vecchia scuola per nuovi lavori?
V. 8 N. 8 (2025)Il mondo del lavoro è in continua e rapida evoluzione, tanto che alcuni lavori odierni erano semplicemente impensabili venti anni fa. Il continuo progresso tecnologico, l’accelerazione informatica, e le conseguenze sul piano sociale e civile che da questa continua evoluzione derivano, incidono direttamente anche sul piano delle esperienze, delle competenze e delle capacità di cui ognuno deve essere dotato, e in primis i giovani e le giovani che dal mondo della scuola devono passare al mondo del lavoro e del vivere in società. D’altra parte, le ultime riforme scolastiche (Moratti, Gelmini, la Buona Scuola) si sono date, tra gli altri, l’obiettivo di mettere in relazione in modi e tempi diversi il mondo della scuola con quello del lavoro. Relazione che dovrebbe realizzarsi non solo sul piano della preparazione professionale, ma anche sul piano di una formazione in grado di integrare nuove modalità dell’esperienza con competenze e saperi che mettano le nuove generazioni nella condizione di affrontare con sicurezza e competenza la società che sta emergendo in questa fase storica. Si nota tuttavia una discrepanza tra un cambiamento istituzionalmente guidato e burocraticamente mediato, quale quello della scuola, e uno che sembra non controllabile né prevedibile, quello del lavoro, che sollecita nuove professionalità e nuove competenze. Sembra a volte che la scuola cerchi affannosamente di rincorrere qualcosa che non si lascia mai prendere, mutando continuamente non solo direzione, ma anche volto.
Questo numero di Dynamis è dedicato, dunque, alla relazione complicata, reale e/o auspicata, tra due “mondi”: quello della scuola da una parte, con le sue attenzioni, i suoi valori, le sue procedure, e quello delle nuove competenze dall’altra, richieste da una società e da un mondo del lavoro in continua evoluzione, spesso indeterminati e rischiosi.
-
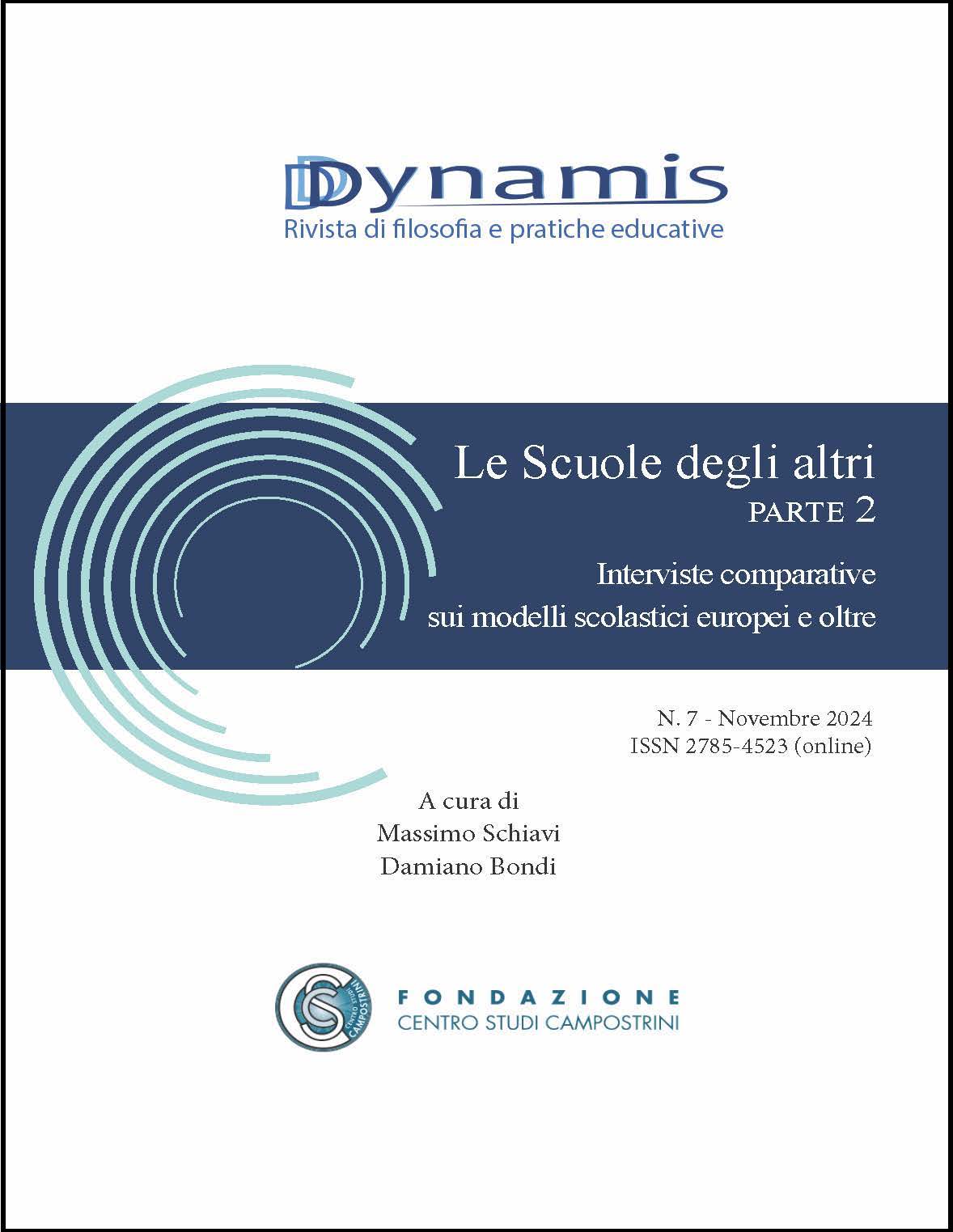
Le scuole degli altri - parte 2
N. 7 (2024)Abbiamo dedicato il numero 5 all'esame dei sistemi scolastici di alcuni paesi diversi dall'Italia, soprattutto europei: Finlandia, Inghilterra, Spagna, Germania, Olanda, Stati Uniti.
Per questo numero abbiamo deciso di ampliare la nostra indagine con una seconda parte, coinvolgendo nuovi paesi: Grecia, Svezia, Francia, Estonia, Svizzera, Cina.
Sentiamo spesso dire, nel dibattito pubblico e sui social, che i sistemi scolastici degli altri paesi sarebbero superiori a quello italiano. Ma è proprio così? Cosa ne sappiamo veramente?
In questo numero vogliamo anzitutto offrire una panoramica sul funzionamento dei sistemi scolastici europei e sui principi pedagogici e antropologici cui si ispirano. Intendiamo poi focalizzarci su alcune problematiche scolastiche, che sono all’ordine del giorno in Italia, per capire come in altri Paesi sono state affrontate: tra queste, l’inclusività, l’interdisciplinarità, l’innovazione digitale, la valutazione. Chiediamo perciò ad esperti dei sistemi scolastici europei, in forma di intervista, di fornirci dei dati e delle opinioni sulle “scuole degli altri”, per migliorare così la nostra.
-

DARE VALORE. La valutazione tra teoria e pratica
N. 6 (2024)La nozione di “valore” sta classicamente a cavallo tra etica ed economia. La sfida di questo numero di DYNAMIS è quella di utilizzare il “valore” come ponte tra l’etica e la scuola, quest’ultima intesa fino nelle sue pratiche più concrete, quale è appunto la valutazione. Ogni settimana, in ogni classe del nostro paese, i docenti assegnano un valore alle performances delle studentesse e degli studenti. E questi ultimi, a metà e a fine anno, si trovano valutati da un giudizio verbale o da un indicatore numerico. Che cosa si sta valutando? Un’esecuzione, un’acquisizione quantitativa di conoscenza oppure un indice di crescita personale? Si può davvero misurare la crescita personale, sulla base delle diverse capacità e impegno individuali? Ancora più in profondità, a cosa serve la valutazione? Quale è il fine che un insegnante persegue valutando i propri studenti, e quali pregiudizi possono essere all’opera in questo processo di giudizio?
Questi e altri interrogativi intendiamo porre agli autori di questo numero di DYNAMIS, cercando anzitutto di fornire un resoconto di come la nozione di valore transiti dalla filosofia alla pedagogia, e di capire poi come possiamo trasformarla al meglio nelle pratiche educative concrete delle nostre scuole.
-

Le Scuole degli altri. Parte 1
N. 5 (2023)Sentiamo spesso dire, nel dibattito pubblico e sui social, che i sistemi scolastici degli altri paesi sarebbero superiori a quello italiano. Ma è proprio così? Cosa ne sappiamo veramente?
In questo numero vogliamo anzitutto offrire una panoramica sul funzionamento dei sistemi scolastici europei e sui principi pedagogici e antropologici cui si ispirano. Intendiamo poi focalizzarci su alcune problematiche scolastiche, che sono all’ordine del giorno in Italia, per capire come in altri Paesi sono state affrontate: tra queste, l’inclusività, l’interdisciplinarità, l’innovazione digitale, la valutazione.
-
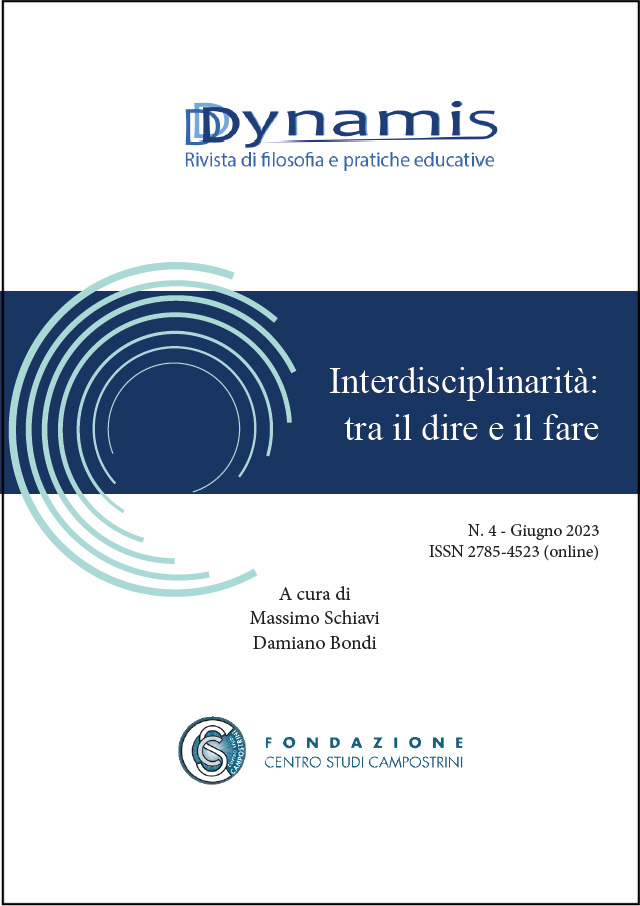
INTERDISCIPLINARITÀ. Tra il dire e il fare
N. 4 (2023)Nel mondo dell’educazione e della ricerca, l’interdisciplinarità è sulla bocca di tutti: nei testi di pedagogia è uno dei lemmi più presenti, a cui sono dedicati interi capitoli; nelle Linee Guida dei Ministeri figura come l’approccio primario per orientare l’attività formativa, scientifica e didattica; l’Unione Europea l’ha posta tra i criteri valutativi principali per il finanziamento della ricerca; l’Università di Oxford ha pure dedicato a questa nozione uno dei suoi celebri Handbooks.
Ma cosa significa esattamente “interdisciplinarità”? E soprattutto, al di là delle buone intenzioni di cui sembrano permeati i numerosi documenti in proposito, cosa comporta realmente progettare, studiare, insegnare e apprendere secondo un metodo interdisciplinare?
-
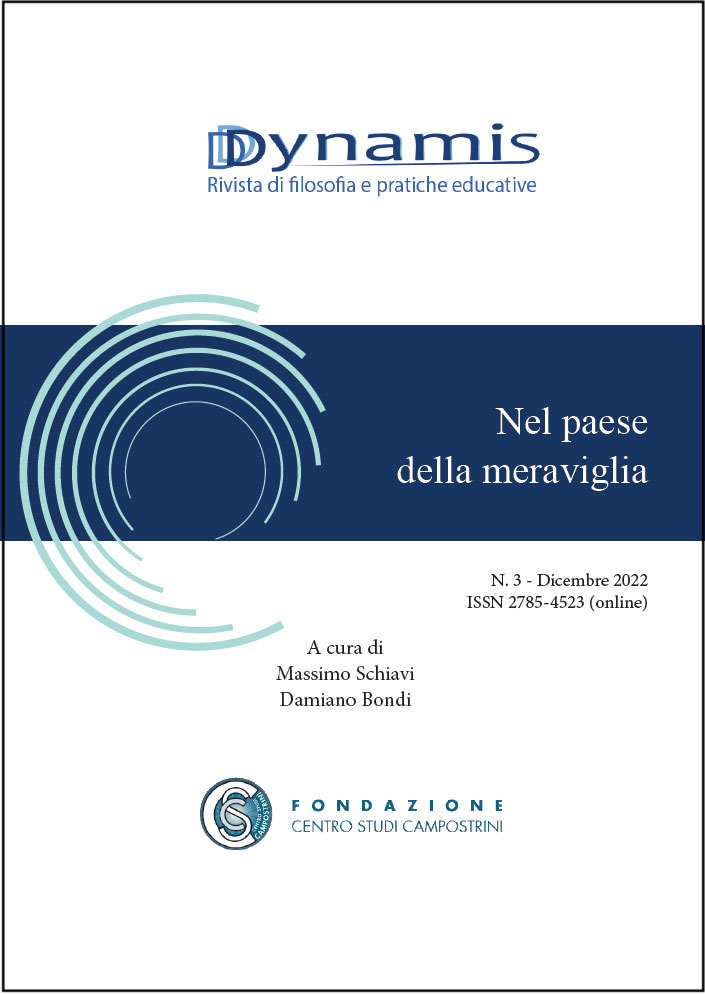
Nel paese della Meraviglia
N. 3 (2022)La perdita della capacità di meravigliarsi è spesso lamentata come una delle cause fondamentali della mancanza di motivazione da parte delle studentesse e degli studenti, e, più in generale, fuori dalle aule scolastiche, delle ragazze e dei ragazzi. Questi non si meraviglierebbero più di niente, e dunque non solo non sarebbero spinti a imparare, ma neanche a impegnarsi in altre attività, con una conseguente caduta in uno stato di accidia e depressione. L’anestetizzazione della facoltà di meravigliarsi è a volte imputata a una costante iperstimolazione da parte del mondo dei social e della comunicazione 3.0, e quindi a un crescente bisogno (indotto) di stimoli sempre nuovi, da una parte sempre più rumorosi, colorati e invadenti, e dall’altra sempre meno esigenti in termini di impegno personale, non solo mentale ma anche temporale. L’esito finale di questa rincorsa allo stimolo sarebbe una sorta di overdose sensoriale che culminerebbe in uno stato di apatia, poiché niente risulterebbe più veramente appetibile.
Cosa può fare la scuola, e in generale il mondo dell’educazione, in tutto ciò? Come risvegliare il senso della meraviglia sopito, e la conseguente motivazione ad “avere a che fare” con il mondo? È auspicabile, o anche solo possibile, voler rincorrere e concorrere con i modelli iperstimolanti del contesto sociale entro cui vivono le giovani generazioni? È auspicabile, o anche solo possibile, fare entrare questi mondi “all’interno” delle istituzioni e delle agenzie educative?
In questo numero di DYNAMIS ci poniamo questi interrogativi, aiutati dalla riflessione di due studiosi contemporanei sul tema della meraviglia. I due articoli di Mario di Paolantonio e Anders Schinkel, in dialogo con prospettive di autori più classici come Dewey, Buber e Arendt, si concentrano sulla meraviglia nell’infanzia e nell’adolescenza.
-

EDUCARE LE EMOZIONI. Il ruolo dell'affettività nelle pratiche educative
N. 2 (2022)A dispetto di un secolare sospetto, quando non disprezzo, con cui la dimensione emotiva è stata guardata e giudicata nella nostra cultura occidentale, assistiamo oggi ad una rivincita delle emozioni. La vita emotiva rappresenta una parte fondamentale dell’essere umano, una parte molto delicata perché espone la persona alle influenze del mondo esterno: una parte, dunque, che chiede di essere educata, non rigettata né tralasciata come secondaria. Si corre tuttavia il rischio di passare da una visione delle emozioni secondo cui esse andrebbero sempre e comunque “tenute sotto controllo”,quando non silenziate, alla visione opposta secondo cui le emozioni sarebbero la nostra “vera voce”, la voce della nostra spontaneità che dovremmo seguire più di ogni altra. In realtà, entrambe queste posizioni, apparentemente inconciliabili, hanno spesso una radice comune: si fondano infatti sull’idea che le emozioni siano qualcosa di “irrazionale”, di opposto al “pensiero”.
La via che proponiamo in questo numero parte invece dal considerare le emozioni come dotate di un valore cognitivo: esse, cioè, riflettono un giudizio, non sempre del tutto cosciente, sul valore che certe persone, certi oggetti, certe situazioni hanno per la nostra vita. Su questa base, è possibile sviluppare una riflessione sull’educazione all’affettività che consideri le emozioni come qualcosa da conoscere per conoscere meglio sé stessi e le proprie relazioni col mondo, come qualcosa da considerare nel compiere le proprie scelte – accanto ad altre considerazioni di ordine razionale, sociale e morale –, e come veicolo per un dialogo interpersonale basato sulla reciproca comprensione. Questa educazione all’affettività è – o dovrebbe essere – uno degli elementi principali attraverso cui si realizza la riflessione pedagogica e si concretizza l’azione educativa. All’interno del sistema scuola ciò vale non solo per gli studenti – la cui educazione all’affettività deve accompagnare l’apprendimento e la costruzione di una propria identità – ma anche per gli insegnanti, chiamati a riflettere sulle proprie gerarchie di emozioni per meglio valorizzare il loro lavoro formativo, e per meglio valutare quella tonalità emotiva nel contesto della quale si radica il rapporto insegnante- studente e la buona riuscita del percorso di formazione.
-
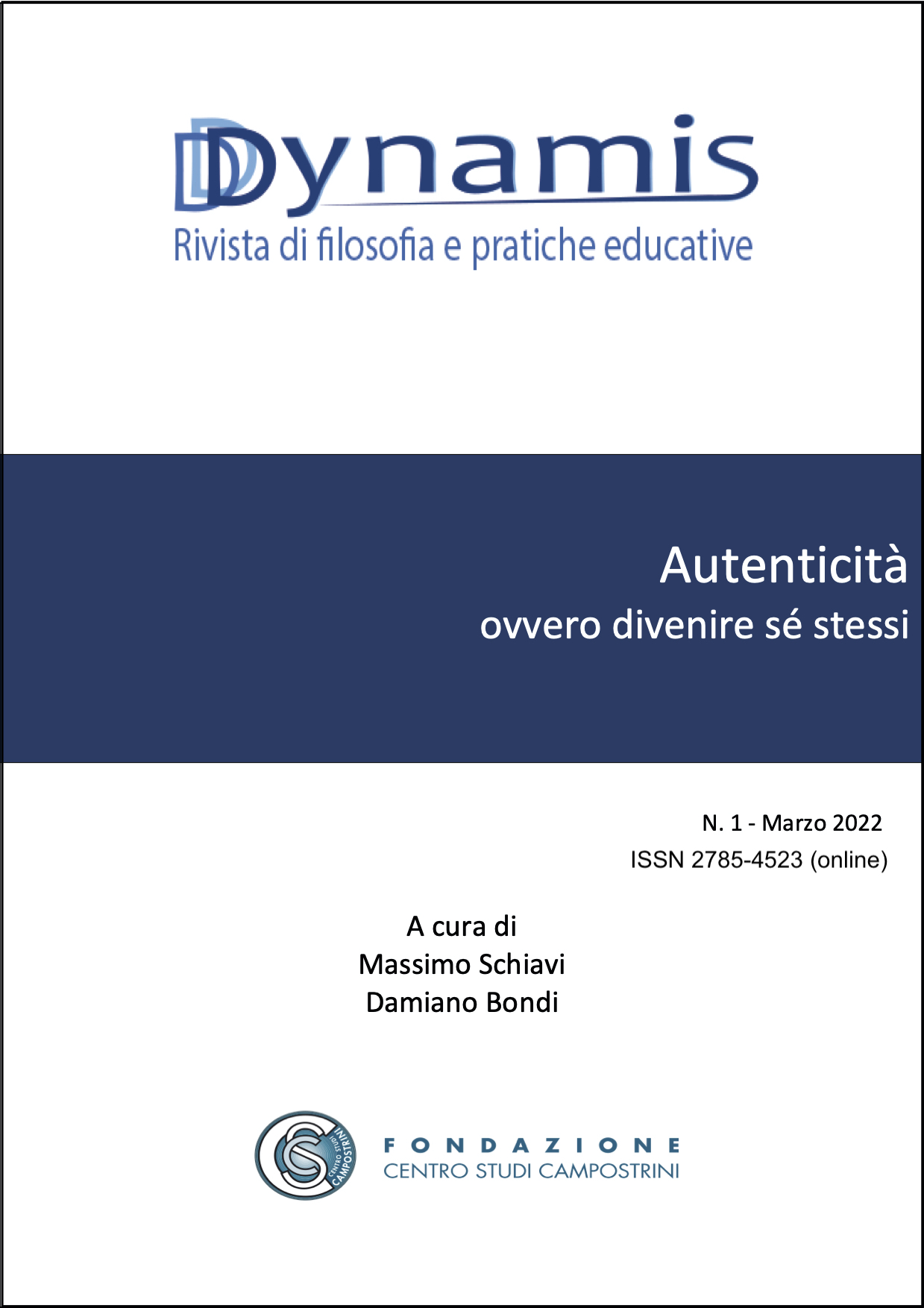
AUTENTICITÀ. Ovvero divenire sé stessi
N. 1 (2022)La scuola è senza dubbio uno dei luoghi principali in cui si costruisce la propria identità. Certo, la conoscenza e la costruzione del sé sono un processo che dura tutta la vita, ma gli anni scolastici sono assolutamente cruciali in tale percorso. La scuola è dunque il luogo dove si forma un primo livello di socialità e dove l’individuo, quasi mai solo con se stesso o unicamente in relazione con le figure parentali, si trova immerso all’interno di un sistema in cui la relazione diventa determinante ai fini della costruzione di sé: della propria identità, dell’autostima, della capacità di affrontare e di dialogare con gli altri. Anche dal percorso scolastico passa, dunque, la costruzione della struttura della personalità, attraverso il ruolo determinante della relazione, della comunicazione e della capacità di discernere tra le proprie emozioni, i propri desideri e attitudini. Alla luce di questo la scuola stessa potrebbe – e forse dovrebbe – essere vista prima di tutto come il luogo e il tempo in cui si impara chi si è e chi si vorrebbe essere, e non solo il luogo dove si apprende o ci si istruisce.
Per indagare questa complessa trama, fatta di legami, di scambi reciproci, di scelte e di momenti di autoconsapevolezza – attraverso cui prende forma l’identità – abbiamo deciso di focalizzarci su un aspetto singolo di questa intricata dinamica, ossia sulla dimensione dell’autenticità: sia perché questa istanza è diventata una sorta di massima ideale della società contemporanea - “Sii te stesso”, “Diventa ciò che sei” o “Diventa ciò che vuoi”, a seconda dei casi, sono degli slogan che sentiamo un po’ ovunque -, sia perché l’autenticità, cioè il corrispondere a se stessi, rappresenta un momento cruciale del più ampio sistema da cui scaturisce la struttura identitaria del soggetto.
Per incoraggiare la riflessione su questo tema proponiamo la traduzione italiana di un articolo sull’autenticità del filosofo francese Claude Romano, che ha il pregio di proporre nuove prospettive partendo da un confronto con le principali riflessioni novecentesche su questa questione (Heidegger, Sartre, Foucault, ecc.). Claude Romano è Maître de Conférences all’Università di Parigi-Sorbonne e membro degli Archivi Husserl di Parigi. È autore di due libri di fenomenologia dell’evento, L’événement et le monde (1998) e L’événement et le temps (1999), e recentemente ha dedicato un’opera corposa proprio al tema dell'autenticità, intitolata “Ètre soi même” (Édition Gallimard, Paris, 2019).



